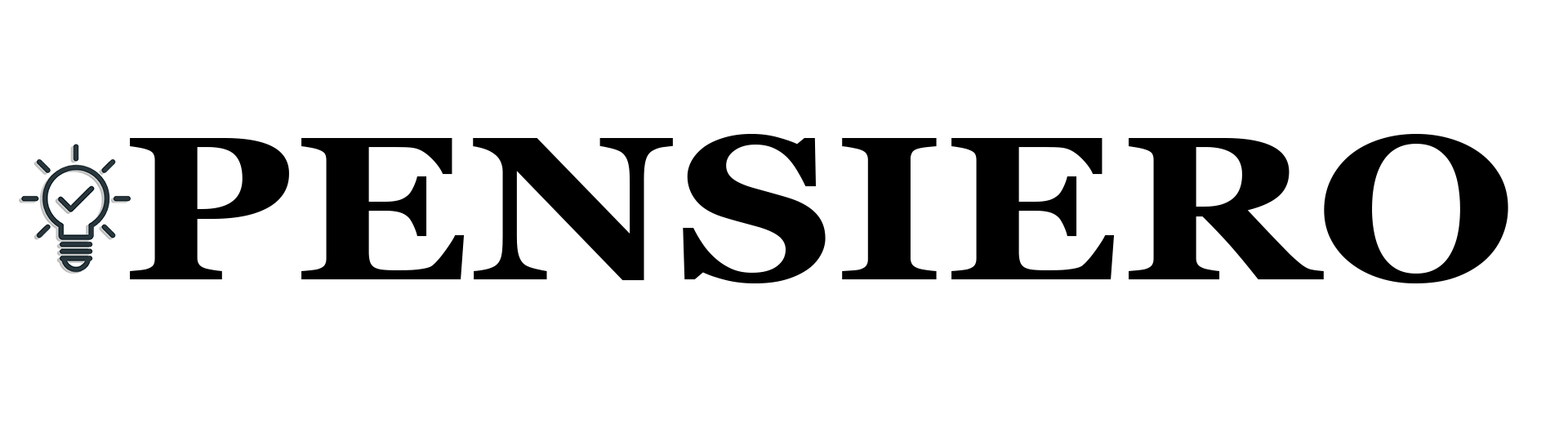Presso una casa d’aste romana nel 2022 appaiono due magnifici dipinti che hanno quale immediato riferimento le “Metamorfosi” di Ovidio, il famoso poema epico-mitologico che è stato d’ispirazione a tanti artisti e umanisti dall’antichità ai giorni nostri; le due tele ritrovate rappresentano “Bacco e Arianna” e “Il trionfo di Venere Anadiomene” che sarebbe andato in asta come “Il trionfo di Galatea”.
Destino vuole che la storica dell’arte ed esperta di restauro Roberta Porfiri intuisce l’alta qualità dei due dipinti, che sono intelaiati dentro cornici più tarde rispetto alla loro esecuzione, e li attribuisce a Sebastiano Ricci.
Le due opere sono di proprietà ENEL spa, che le ritira dalla vendita e allo stesso tempo promuove e finanzia il loro restauro. Si rivela un’impresa difficile individuarne la committenza e la collocazione originaria, possiamo solo sapere con certezza che, in precedenza ma sempre in tempi molto vicini a noi, erano di “Proprietà S.I.P.” (Società Idroelettrica Piemontese).
Sebastiano Ricci è il ponte, grazie alla sua maniera neoveronesiana, tra il seicento e la futura genialità pittorica di Gian Battista Tiepolo, confermandosi comunque egli come l’iniziatore di un nuovo stile: il Rococò, tanto amato dai francesi e che consentirà a questi di riconoscere nell’artista una consonanza di spirito.
Il Ricci è un bellunese, che approfondisce i suoi studi giovanili a Venezia, dove assorbe nella sua pittura l’aria tersa e luminosa della Laguna, i colori accesi dalla luce, le atmosfere brillanti della magnifica città di San Marco. A qualsiasi artista occorra nella propria vita d’incontrare Venezia, ne verrà fuori da questa esperienza metafisica e mistica completamente abbagliato e toccato nei sensi e nelle emozioni.
Accadde a William Turner che, conoscendo Venezia, se ne innamorò e finì per giungere ad anticipare nelle sue opere l’uso della luce che gli Impressionisti francesi metteranno a frutto nelle loro.

Colori e luce nelle incantevoli Madonne di Giovanni Bellini sono la prova e la testimonianza del suo innamoramento e del suo debito passionale verso la famosa Repubblica Marinara. La Porfiri, nel suo articolo “Nuove aggiunte al catalogo di Sebastiano Ricci – Due tele inedite di Enel S.P.A.” pubblicato dalla rivista “Studi di Storia dell’Arte” n.34 del 2023 edita da ediart e successivamente nel suo testo del catalogo virtuale “L’incanto della Bellezza. Dipinti ritrovati di Sebastiano Ricci dalla collezione Enel” dedicato alla mostra, che si terrà fino al 18 maggio presso il Museo di Roma a Palazzo Braschi, mette in evidenza il possibile e assai credibile collegamento di queste opere ritrovate e riscoperte con il momento fiorentino del Ricci il cui influsso si prolungherà fino alla sua partenza per l’Inghilterra pur non risiedendo più egli nella città dei Medici e passando piuttosto per Venezia.
Il pittore Niccolò Cassana, che lavorava per il Gran Principe Ferdinando de’ Medici, aveva favorito l’incontro tra questi e il Ricci che entrarono così, grazie a lui, in stretti rapporti di amicizia, come testimonia lo scambio di lettere fra loro risalente al 1706; a riprova dell’intesa e del dialogo esistente fra i due, Sebastiano Ricci lavorerà per il Gran Principe a Palazzo Pitti e nella villa di Poggio a Caiano, andata distrutta nel XIX secolo. Le due ritrovate tele del bellunese dalla Porfiri vengono così fatte risalire a un periodo, con ogni probabilità, antecedente al 1708, quindi alla fase giovanile più matura e più densa di aspettative e promesse del Ricci.

Da riscontrare anche l’importante contatto dell’artista veneto con la scuola emiliana che egli incontrerà a Bologna e a Parma per il tramite di Carlo Cignani, seguace di Annibale Carracci e del Correggio, che frequenterà e di cui potrà vedere la decorazione murale nella Sala dell’Amore del Palazzo del Giardino di Parma (lavori portati avanti ed eseguiti tra il 1678 e il 1680): in questa Sala il Cignani aveva dipinto un “Bacco e Arianna” dalla composizione ampia e dilatata, non scorciata come quella di soggetto analogo del Ricci, ma somigliante a quest’ultima per la sequenza dei personaggi; nel medesimo ambiente Sebastiano Ricci avrà potuto ammirare nel soffitto il dipinto murale di “Peleo e Teti” di Agostino Carracci che ricorda per atteggiamento e formosità della ninfa l’Arianna della sua rinvenuta tela.
Nella formazione del Ricci riveste fondamentale importanza il periodo legato a Roma dove l’artista arriverà nel 1691, con l’autorevolezza di una “patente di familiarità” del Duca Ranuccio II Farnese, e alloggerà presso il Palazzo di questa nobile e importante famiglia. A Palazzo Farnese l’artista resterà impressionato e colpito dalla Galleria dei Carracci che avrà una successiva e notevole influenza sulla sua produzione futura. L’illusionismo vertiginoso del Pietro da Cortona di Palazzo Barberini, della Chiesa del Gesù di Giovan Battista Gaulli e del soffitto di Sant’Ignazio di Andrea Pozzo incise profondamente sulla qualità pittorica aggettante e scorciata del Ricci che si sarebbe andata a completare e ad arricchire di raffinati stucchi.
Sebastiano Ricci coltivava la passione, come molti artisti, alimentata chiaramente dal successo tematico e iconografico di un’opera, di realizzare più volte lo stesso soggetto come è possibile verificare nel caso specifico del “Bacco e Arianna” e come ben lo pone in evidenza la stessa Porfiri nei suoi interventi scritti: naturalmente l’artista situava diversamente le figure sulla scena e creava una differente prospettiva.
L’elemento che tendeva a contraddistinguere una versione dall’altra era il livello di finitezza formale. Si può affermare, senza esitazione, che i due dipinti presi in esame esprimono una finitezza sublime e che di conseguenza, come ipotizza giustamente la storica dell’arte, possano farsi risalire a una committenza importante, con ogni probabilità toscana e che siano stati realizzati con l’occasione di un matrimonio di alto prestigio.
Le due splendide tele, salvate provvidenzialmente da una possibile dispersione sul mercato collezionistico o antiquario che ne avrebbe impedito la pubblica fruizione, sono pervase dall’amore che, nel caso di Arianna, trionfa sul dolore dell’abbandono in quanto lei, lasciata da Teseo addormentata sull’isola di Nasso, nel risvegliarsi trova la divina sorpresa di Bacco che la contempla innamorato e che la omaggerà infine quale sua sposa con il dono della costellazione della Corona Borealis: si tratta di una donna, a buon diritto invidiabile, che dall’uomo che l’ama e che la prende in moglie, sottraendola così alla solitudine e alle delusioni della vita, viene nominata e incoronata regina non solo del suo cuore ma dell’universo celeste.
Soggetto dell’altra tela è Venere Anadiomene che, con la sua bella veste lapislazzuli, sorge dal mare e che con le redini, aggioganti il delfino stupito e innamorato, forma con le dita di una mano con elegante grazia il nodo d’amore destinato a vincolare per sempre due anime, nel mentre la Dea indica divertita con l’altra mano l’amorino al quale un tritone rivolge il suo sguardo e lei Dea dell’Amore guarda maliziosamente all’esterno verso di noi, richiamando la nostra attenzione sul laccio che inevitabilmente catturerà i nostri cuori. I tritoni e le nereidi, che fanno da corteo a Venere, sono in preda all’estasi del sentimento d’amore che li rende tutti vulnerabili e complici del momento magico e sognante, appartenente al mito.
Per concludere, la Teti di Agostino Carracci, del Palazzo del Giardino a Parma, è anch’essa una nereide, la più bella tra le ninfe del mare, che tenta di sfuggire alle tenaci insistenze amorose di Peleo, trasformandosi continuamente in serpente, in leone e in fuoco ma che non riesce ad avere la meglio sull’innamorato e che infine lo sposa. All’amore nessuno può sfuggire, prima o poi ti raggiunge per sorprenderti e farti vivere lo stupore senza fine, esattamente come accade nel mito.
L’esposizione “L’incanto della bellezza. Dipinti ritrovati di Sebastiano Ricci dalla Collezione Enel” è visitabile fino al 18 maggio presso le sale del terzo piano del Museo di Roma a Palazzo Braschi, è a cura di Roberta Porfiri, organizzata da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, Sovrintendenza Capitolina ai Beni culturali e da Enel che si è avvalsa per il restauro della collaborazione della Soprintendenza Speciale di Roma – Archeologia Belle Arti e Paesaggio. Servizi museali di Zètema Progetto Cultura.Ingresso alla mostra gratuito con il biglietto del Museo, secondo tariffazione vigente (gratuito con RomaMIC Card).Museo di Roma – Palazzo Braschi, Piazza San Pantaleo 10 – 00186 Roma, dal martedì alla domenica ore 10:00 – 19:00, giorno di chiusura 1 maggio; Per info: 060608; Mail: museodiroma@comune.roma.it
Leggi anche:
- Un pastore con l’odore delle pecore
- Il Conclave 2025: tra attese, speranze e il bisogno di un pontefice che ricomponga la Chiesa
- Il fenomeno Dimash Qudaibergen
- Il coraggio di essere autentici in un mondo conformista
- Inchiesta sulle indulgenze (Seconda Parte)