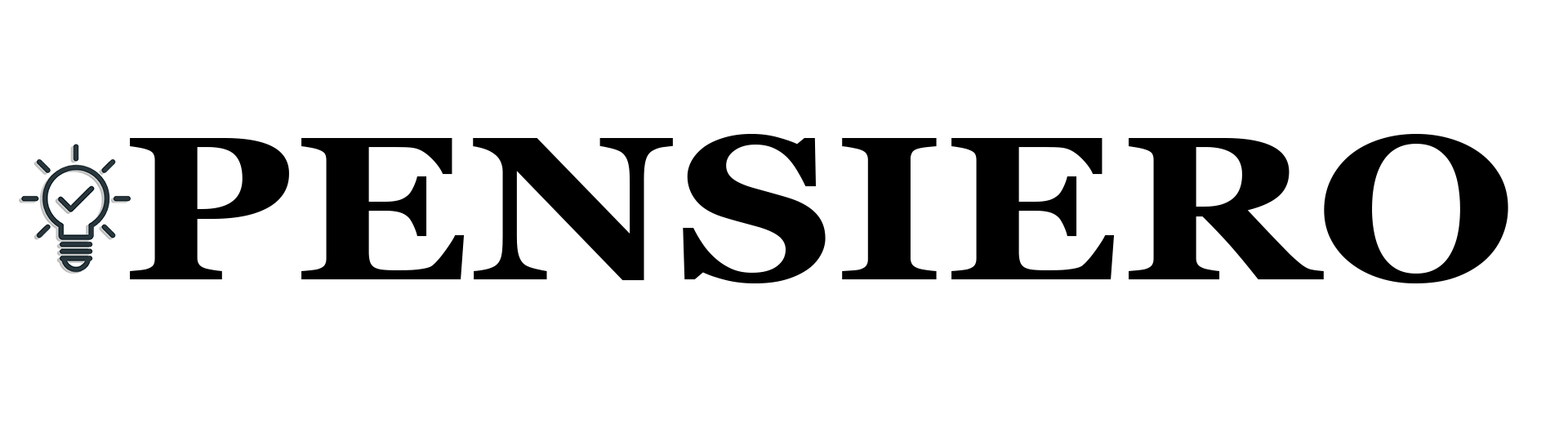Nella prima parte del presente articolo abbiamo ricostruito per lineamenti generali, e tuttavia con la massima precisione consentita dalla brevità e dal necessario taglio divulgativo, la genesi storica della dottrina delle indulgenze e del corrispondente rito, assistendo all’emergere del suo radicamento nella Rivelazione come concepita dalla teologia cattolica, quindi come coacervo di Sacra Scrittura, Tradizione e Magistero ecclesiastico. Con tali presupposti, procediamo ad una rapida sintesi dottrinale della nozione di indulgenza, per poi tornare nell’ottica della storiografia ripercorrendo l’origine della posizione luterana in merito al nostro tema, e quindi per analizzare le ragioni del confronto coi cattolici.
Sintesi dottrinale
Cos’è dunque l’indulgenza plenaria? Anzitutto dichiariamo cosa non sia, giacché molto spesso è oggetto di un grossolano equivoco: essa non consiste nel perdono delle colpe, per le quali si ricorre alla confessione sacramentale; consiste invece nella remissione delle pene corrispondenti alle colpe medesime. E dunque: la confessione ottiene l’assoluzione dai peccati ma non l’annullamento delle pene che ne conseguono, che il fedele dovrà espiare con un opportuno cammino penitenziale in terra o con una determinata permanenza in purgatorio; oppure, celebrando adeguatamente l’indulgenza, esse verranno rimesse – come sostituite – dal suddetto tesoro della Chiesa ovvero dai meriti infiniti di Cristo e da quelli dei santi. Detti meriti suppliscono, e il fedele viene liberato. Questo, per tratti generalissimi, è il concetto di indulgenza elaborato dalla teologia cristiana cattolica.
Presso le chiese protestanti
I cristiani, si sa, non sono esclusivamente cattolici; il cristianesimo occidentale, infatti, ha subìto il pesante vulnus dello scisma nel 1517 – questa è la data, in parte convenzionale, cui si fa risalire la Riforma Protestante. La quale, a livello dottrinale, inizia proprio come contestazione della dottrina dell’indulgenza. Ma andiamo con ordine. Lutero, integerrimo monaco agostiniano, principiò eccependo non le indulgenze in quanto tali bensì la loro indebita compravendita, che tra Sassonia e Renania veniva praticata con modalità ancora più scandalose da un domenicano di nome Johann Tetzel, il quale agiva nientemeno che per conto di Alberto vescovo di Brandeburgo. Sostanzialmente si lucrava col culto, e Lutero che ne ebbe diretta contezza s’indignò tanto fortemente quanto giustamente.
Ma questo fu solo l’inizio poiché, cessata detta compravendita, egli si scagliò contro la dottrina/pratica dell’indulgenza in quanto tale, al punto che oggi un’ampia porzione della cristianità occidentale – quella protestante e riformata – non la celebra affatto anzi la rifiuta. Siamo per l’appunto nel 1517, il nostro monaco si professa ancora cattolico e in comunione col Papa e, convinto di perseguire il miglior bene della Chiesa, cerca di spiegare la propria posizione teologica o meglio le sue perplessità circa le indulgenze, forse con un eccesso di irruenza; pertanto scrive la Disputatio pro declaratione virtutis indulgentiarum, più nota come Novantacinque tesi – sulla storicità dell’atto con cui le affisse alla porta della cattedrale di Wittenberg non occorre pronunziarsi, poiché la questione non incide minimamente sui fatti e sulla loro ricostruzione. A questo livello, in buona sostanza, Lutero obietta circa l’estensione del potere spirituale del Papa, cioè non crede che possa fondare l’indulgenza ovverosia sciogliere i fedeli dalle proprie pene; di qui le sue perplessità sull’indulgenza stessa.
Tuttavia, la teologia definitiva del riformatore ne rifiuterà la dottrina perché non radicata nella Sacra Scrittura. Si tenga presente, infatti, l’equazione luterana tra Rivelazione e Sacra Scrittura: né attraverso la Tradizione, né attraverso il Magistero ecclesiastico Iddio si rivela agli uomini, ma solo mediante la Bibbia – è il primo e fondamentale principio teoretico della teologia di Lutero, quello della Sola Scriptura. Ebbene, le indulgenze non sono una realtà da professare/celebrare perché non sono menzionate nella Rivelazione/Bibbia – questa la posizione finale di Lutero e delle chiese luterane. Il discrimine tra l’accettazione e il rifiuto delle indulgenze, come l’attento lettore avrà già compreso, sta in una diversa concezione della Rivelazione: per i cattolici – si veda l’altra parte dell’articolo – essa si storicizza nella Scrittura, nella Tradizione e nel Magistero, per i protestanti nella sola Scrittura, e ciò che non figura in essa deve essere reciso.
In realtà – e nuovamente rimandiamo alla prima parte dell’articolo nel precedente numero de Il Pensiero settimanale – l’indulgenza ha un certo fondamento biblico in Mt 16,18-20, ma riconoscerlo avrebbe comportato contestualmente il riconoscimento del Primato Petrino, atto impensabile per quel Lutero che, al culmine dello scontro con Roma, diffuse a mezzo di stampa una caricatura in cui Papa Leone X veniva rappresentato con la faccia a forma di deretano! Il resto della storia è noto a tutti.
Considerazioni conclusive
Volendo esprimere una valutazione di tipo accademico – ovviamente non confessionale – circa la disputa sulle indulgenze, a nostro avviso è necessario rilevare un’incongruenza a monte ovvero nel concetto luterano di Rivelazione, in base al quale l’indulgenza viene rifiutata: Lutero rigetta la Tradizione ed eleva al rango di Parola di Dio la sola Bibbia; ma, storicamente parlando, la Bibbia non è che la condensazione scritta della Tradizione, dunque andrebbero o respinte entrambe o accolte entrambe, pena la contraddizione. E ancora, volendo esprimere una valutazione sulla indulgenza in se stessa ovvero come celebrata dai cattolici, occorre rilevarne l’esclusività in quanto si tratta di un rito riservato, di un’azione liturgica non comunicabile al mondo laico, poiché le sue ragioni sono tutte e totalmente interne al cattolicesimo. Il che non segna affatto un limite o un difetto, solo si vuole sottolineare la sua peculiarità nell’era della globalizzazione e del laicismo giacobino.
D’altronde non tutto il messaggio cristiano può avere un corrispettivo religiosamente neutro ovverosia laico, e forse ciò è un bene giacché preservata l’esperienza religiosa in quanto tale. Infatti nel rito di qualunque genere e appartenenza – come rileva la fenomenologia delle religioni – l’uomo sperimenta la propria dimensione spirituale di apertura e tensione verso l’Altro e verso l’Oltre.
Leggi anche:
- Un pastore con l’odore delle pecore
- Il Conclave 2025: tra attese, speranze e il bisogno di un pontefice che ricomponga la Chiesa
- Il fenomeno Dimash Qudaibergen
- Il coraggio di essere autentici in un mondo conformista
- Inchiesta sulle indulgenze (Seconda Parte)